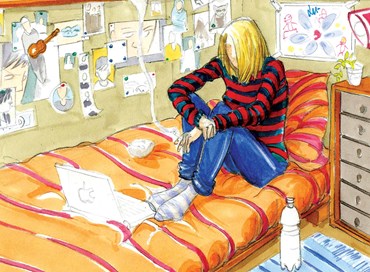
“Neet”. Ovvero, “not (engaged) in education, employment or training”, definizione quest’ultima che riguarda un’ampia fascia demografica di giovani che non lavorano né studiano, o che il lavoro, data l’attuale situazione di crisi, hanno smesso da tempo di cercarlo. Secondo le statistiche europee, l’Italia ha il triste primato dei “Neet”. Ma, “al netto” dei Neet che cosa troviamo? Gente che, per esempio, è parcheggiata da decenni come fuori corso in facoltà che non terminerà mai; come moltissimi altri giovani in formazione permanente continua fino ai trenta/quaranta anni, presi in trappola nella miriade di corsi che non formano a nulla, ma che assorbono ingenti aiuti finanziari europei per mantenere floride le relative aziende di servizi e, soprattutto, per dare lavoro a un esercito di formatori delle più variopinte specie e sottoculture professionali. Il problema, in tal senso, è quello della simbiotica collusione tra utenza e pseudo professionisti della formazione, in quanto sia gli uni che gli altri necessitano del reciproco sostegno per l’accesso ai sussidi e ai contributi degli enti pubblici nazionali e locali, mantenendo in piedi la finzione del ciclo formazione-lavoro, di cui scarseggia drammaticamente proprio l’ultima componente: il lavoro, per l’appunto.
Altro segmento, vittima e carnefice allo stesso modo di questo perverso sistema del Nulla, è dato proprio dalla produttività universitaria. Diciamo subito che, da alcuni decenni, il meccanismo relativo privilegia ancora una volta i garantiti (professori e ricercatori a tempo indeterminato), la cui base si è accresciuta in modo abnorme grazie alla sciagurata riforma delle lauree triennali e specialistiche, con la relativa gemmazione social popolare a tutto campo dei corsi semestrali. Ancora una volta, il disastro al quale assistiamo è stato volutamente programmato per creare una cospicua occupazione fittizia “blindata”, grazie alla moltiplicazione di corsi di laurea di assoluta fantasia, che offrono come sbocco il suddetto Nulla. Ma, intanto, le famiglie italiane che hanno studenti da mantenere all’università, per ben più di un lustro mediamente, sono sempre meno orientate a fare sacrifici inutili, smentendo il detto storico “meglio un figlio dottore che operaio”, visto che la maggior parte dei laureati si trova poi a dover scegliere lavori precari ben al di sotto del titolo di studio posseduto. E qui arriviamo alla parte più invisibile dei “Non-Neet”: l’esercito di giovani italiani che, con qualifiche più o meno elevate, si è rifugiato per così dire all’estero, chiedendo non di rado notevoli sacrifici alle famiglie per il proprio mantenimento.
In altri miei interventi ho raccontato come anche questo aspetto (mandare i figli all’estero a studiare seriamente, anche con la prospettiva di non rivederli mai più, se non per brevi periodi di vacanza) sia diventato terribilmente più difficile, dopo che in quindici anni, dal 2002 a oggi, i risparmi delle famiglie italiane sono stati falcidiati dall’euro e dal costo triplicato dei prodotti alimentari di base, come frutta e verdura. Per non parlare della bolla immobiliare: a cavallo tra il 2001 e il 2002 i prezzi degli immobili (gli stessi di prima!) e degli affitti sono letteralmente raddoppiati, come pure ovviamente i ratei dei mutui. Quindi, tutti coloro che avevano messo le proprie liquidazioni da parte, erogate in lire e convertite al centesimo in euro, si sono trovati a non poter più acquistare un alloggio per i figli divenuti grandi (con conseguente crollo delle nascite!), dato che, tra l’altro, il raddoppio letterale del costo della vita ha obbligato molti cittadini a reddito fisso ad attingere con sempre maggiore frequenza al risparmio accumulato, anche per continuare a mantenere in casa figli già grandi. Da lì nasce la scelta obbligata: le famiglie con ancora risparmi sufficienti non comprano più l’abitazione ai figli ma investono le risorse residue per mandarli a studiare all’estero, sperando come ritorno di quei sofferti investimenti la conquista di un posto di lavoro adeguato alle loro aspirazioni.
Questo per le (drammatiche) statistiche. Due parole sui rimedi. Quanti di noi si lamentano (e pagano in nero salmodiando) perché non si trovano idraulici, falegnami, restauratori, pittori, etc., se non supplicando e facendo simboliche code chilometriche per accaparrarsi il riparatore/aggiustatore di turno? Ma, come si fa con i pochi, bravi artigiani anziani rimasti in pista a riciclare milioni di giovani diseducati al lavoro manuale, sempre più disprezzato, interessati soltanto alle meraviglie dell’economia digitale, delle App e dei mille mestieri improbabili che nascono e rapidamente scompaiono nella Rete? Come si fa ad educare un popolo intero, una volta parco, a rinunciare all’acquisto compulsivo di qualche quintale di “stracci” all’anno procapite, solo per indossare al massimo un paio di volte pessimo vestiario senza un’ombra di gusto e di eleganza, che viene dalle produzioni anonime di Cindia (Cina + India)? Come si fa a tornare alle cose che si possono riparare, per le quali è prevista una vita medio-lunga e che sono prodotti di un artigianato di qualità che fa bella la vita?
Le filiere da ricostruire (prima di tutto e sommamente nelle menti e negli spiriti) sono quelle del gusto artistico nel cibo, negli indumenti, negli accessori e, soprattutto, nel potere immenso delle mani che conoscono e sanno lavorare i materiali veri, non quelli virtuali. E questa, aggiunta al rilancio in grande stile dell’agricoltura di qualità, è la sola ricetta che ci può salvare dalla desertificazione industriale attuale.
Aggiornato il 18 luglio 2017 alle ore 21:49



